Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia di coronavirus: da quando il virus è arrivato a fine febbraio in Occidente e si è poi diffuso in tutto il mondo, ogni altro argomento è passato in secondo piano. L’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere colpito dopo la Cina, e con oltre 2 milioni di casi confermati e 70 mila decessi è uno dei paesi che ha più sofferto la pandemia. In questo articolo proviamo allora a ripercorrere cosa è successo in questi 12 mesi difficili.
Gennaio: tutto parte dalla Cina
Il primo caso noto di infezione da SARS-CoV-2 (acronimo dall’inglese severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) è stato registrato in Cina il 1° dicembre 2019, ma solo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio a Wuhan, nella provincia dell’Hubei, le autorità sanitarie si sono rese conto della presenza di un’epidemia di polmoniti sospette. La comunità scientifica concorda sul fatto che il coronavirus abbia un’origine naturale e che molto probabilmente abbia fatto il cosiddetto “salto di specie”, passando dal pipistrello all’uomo.
L’Organizzazione mondiale della sanità, che il 31 dicembre viene a conoscenza per la prima volta delle polmoniti di origine ignota a Wuhan, dichiara un’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale a gennaio e poi la pandemia a marzo.
Alla fine di gennaio l’Italia implementa alcune misure preventive negli aeroporti, come il controllo della temperatura delle persone che arrivano nel nostro Paese. All’epoca si pensava ancora che gli asintomatici non potessero trasmettere il virus e che quindi bisognasse preoccuparsi solo di chi presentava dei sintomi. Ora, invece, sappiamo che gli asintomatici hanno un ruolo fondamentale: secondo alcuni studi sono responsabili di 7 infezioni su 10.
Asymptomatic #2019nCoV infection may be rare, and transmission from an asymptomatic person is very rare with other coronaviruses, as we have seen with MERS. Thus, transmission from asymptomatic cases is likely not a major driver of transmission https://t.co/5gEHSOGO7H pic.twitter.com/Zh8ifwP4XA
— World Health Organization (WHO) (@WHO) 1 febbraio 2020
Il 30 gennaio due turisti cinesi in Italia da alcuni giorni si rivelano positivi e vengono ricoverati allo Spallanzani di Roma. L’Italia decide così di sospendere i voli dalla Cina.
Febbraio: Codogno e la scoperta che il virus era in Italia
Nonostante i due turisti cinesi positivi, si pensava che il virus non circolasse nel nostro Paese. Tuttavia, il 18 febbraio un 38enne di Castiglione d’Adda si reca al pronto soccorso di Codogno, un comune del basso lodigiano, con i sintomi di una polmonite: dopo aver scelto di non farsi ricoverare, il suo quadro clinico peggiora e quando ritorna in ospedale viene sottoposto a tampone. Lì risulta essere positivo, come sua moglie, anche se nessuno dei due è stato recentemente in Cina: dal momento che non è possibile capire chi ha contagiato Mattia, egli viene definito “paziente uno” e non “paziente zero”.
In pochi giorni i casi di positività iniziano a moltiplicarsi nel Paese, in particolar modo in Lombardia, che si trasforma da lì a poco nell’epicentro della pandemia in Italia. In poco tempo nascono focolai, termine con cui si indicano due o più casi collegati, in tutto il Paese, e il 2 marzo in ogni regione italiana c’è almeno una persona positiva al coronavirus. In Veneto dopo la positività di due residenti di Vo’, un comune del padovano, il presidente della regione Luca Zaia decide di sottoporre tutti gli abitanti del comune al tampone molecolare, trovando l’1,7% di positivi.
Nonostante alcune teorie suggeriscano che il virus circolasse già in Italia addirittura nel 2019, al momento non vi sono reali prove che sia così. Anzi, tutti i dati tendono a smentire questa idea, come si vedrà successivamente.
Marzo-aprile: il lockdown e la crescita dei casi
Inizialmente il 21 febbraio il governo decide di mettere in quarantena sia diversi comuni del basso lodigiano, tra cui Codogno, sia Vo’, ritenendo la circolazione del virus ancora circoscritta e circoscrivibile. Ben presto, però, si scopre che così non è, e l’8 marzo il Governo, con un DPCM, mette in zona rossa tutta la Lombardia e altre 12 province del Nord Italia.
Sono proprio della sera dell’8 marzo le immagini delle persone che si recano a prendere i primi treni disponibili per uscire dalla Lombardia e dalle province colpite, prima che venga stabilita la zona rossa: per tutta la sera dell’8 marzo, infatti, circolano già bozze e indiscrezioni sulle possibili decisioni del Governo.
Già il 9 marzo il Governo estende il divieto di spostamenti non necessari a tutto il Paese e procede con le prime chiusure. L’11 marzo, poi, il Governo annuncia il decreto “Io resto a casa”, con il quale tutta l’Italia venne messa in lockdown: bar, ristoranti e servizi non essenziali vengono chiusi e ogni movimento non necessario diventa vietato. L’obiettivo è quello di ridurre le interazioni sociali al fine di limitare i contagi, e con questa decisione l’Italia diventa il primo Paese dopo la Cina ad adottare una decisione simile.
L’imposizione del lockdown mostra rapidamente i suoi effetti, anche se a marzo non sono ancora così chiari. Gli studi scientifici affermano che il periodo di incubazione, cioè il tempo che passa tra quando ci si contagia e quando si manifestano i sintomi, è di circa cinque giorni. L’Istituto superiore di sanità (Iss) pubblica inoltre da alcuni mesi i casi sintomatici per la data in cui hanno iniziato a sviluppare i sintomi: questa curva, in media mobile, ha un picco il 16 marzo, esattamente cinque giorni dopo l’inizio del lockdown, mostrando quindi come le restrizioni abbiano portato ad una riduzione dei contagi pressoché da subito.
Questo, però, non è chiaro sin dall’inizio: i dati diffusi dalla Protezione civile sono infatti affetti da numerosissimi ritardi. All’epoca, secondo l’Iss, passavano in media cinque giorni tra quando si manifestavano i sintomi e quando si veniva sottoposti al tampone. Tuttavia, tra quando veniva prelevato il tampone e quando si aveva il risultato passavano almeno altri tre giorni: questo ha portato a registrare il picco dei casi per data di notifica, sempre in media mobile a 7 giorni, solo il 26 marzo.
Tra l’imposizione del lockdown e il picco della prima ondata si è passati da poco più di 1.000 casi a circa 6.000. Nel frattempo, il 22 marzo il Governo decide, con un nuovo DPCM, di sospendere anche le attività produttive ritenute non essenziali, ritenendo che le misure precedenti non abbiano ancora avuto effetto.
Queste decisioni permettono di limitare la circolazione del virus nelle regioni settentrionali e in particolar modo in Lombardia, mentre le regioni meridionali vengono toccate, in questa prima ondata, solo marginalmente.
Ora sappiamo anche che i numeri che si registravano all’epoca davano solo un’indicazione di massima di ciò che stava succedendo, perché in realtà erano molto lontani dalla realtà: a marzo, infatti, il numero di tamponi molecolari eseguiti era molto basso e fino al 25% di questi risultava positivo. L’Oms ritiene che per avere un’epidemia sotto controllo questa percentuale debba essere inferiore al 5%, mentre altri fissano questa soglia anche più in basso (3%).
Uno dei motivi dei pochi tamponi risiede nelle scelte del Governo: il Ministero della salute, seguendo le linee guida dell’Oms, stabilisce che deve essere sottoposto a tampone solo chi ha sintomi sospetti. Il 27 febbraio Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, critica quindi pubblicamente il Veneto, dove i tamponi possono essere fatti anche agli asintomatici. Va però considerato che era pressoché impossibile incrementare di molto in pochi giorni la capacità di testing, a causa dei limiti di personale e carenza, almeno in quella fase, di macchinari e reagenti.
Nello stesso periodo, in Lombardia anche chi ha chiari sintomi e sta male non riesce a fare un tampone, a meno che non abbia un quadro clinico grave o debba recarsi in ospedale: questo appare evidente sostanzialmente a tutti, ma il presidente della regione Attilio Fontana nega che sia così.
Per diversi mesi si è quindi avuta una fortissima sottostima di casi e decessi. Successivamente, l’indagine di sieroprevalenza condotta da Iss e Istat ha stimato che fino a luglio si sono contagiate 1,5 milioni di persone, il 2,5% della popolazione italiana. Complessivamente, quindi, nella prima ondata è stato intercettato circa un caso su sei.
Il picco dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti arriva nei primi giorni di aprile, quando si toccano rispettivamente oltre 4.000 e 29.000 ricoverati. Le terapie intensive, in particolare, costituiscono una fonte di forte preoccupazione, perché insufficienti per tutti coloro che ne hanno bisogno. Per esempio, la Lombardia ha poco più di 800 posti letto ordinari e deve aggiungerne oltre 600 per cercare di stare al passo.
Nonostante i nuovi posti di terapia intensiva, la maggior parte delle vittime non è morta lì. Anche questo, ancora oggi, non è molto chiaro, ma l’assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera nelle conferenze stampa lo ha detto diverse volte: il 31 marzo, ad esempio, comunica che in rianimazione sono decedute 824 persone e ne sono state dimesse 603. Considerando i posti occupati dai pazienti Covid-19, ciò vuol dire che al di fuori delle terapia intensiva sono decedute 6.375 persone. Una ricerca scientifica successiva ha inoltre evidenziato come circa metà dei pazienti entrata in terapia intensiva sia deceduta.
In primavera non è neanche del tutto chiaro come vengano contati i guariti. Un documento del 28 febbraio 2020, pubblicato dal Consiglio superiore della sanità, stabilisce: “Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi da infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2”. In realtà si capisce ben presto che la definizione non viene seguita nei bollettini: nel computo dei guariti, infatti, inizialmente vengono inseriti sia coloro che non presentano più sintomi (i cosiddetti “guariti clinici”) sia coloro che si sono effettivamente negativizzati (i “guariti virologici”). Ma in aggiunta a questi anche i dimessi vengono contati tra i guariti, così come chi è solo passato dal pronto soccorso e poi è tornato a casa. Il tutto unito al fatto che ogni regione continua a seguire standard propri.
Il disastro di Bergamo
A inizio marzo si capisce poco di quello che sta succedendo e l’opaca comunicazione dei vertici lombardi non aiuta. Ma a Bergamo si sta verificando una tragedia su enorme scala: qui il coronavirus si è ampiamente diffuso e ha portato ad un altissimo numero di decessi.
La prima volta che nel resto d’Italia si capisce cosa sta accadendo nel bergamasco è il 13 marzo, quando sui social network gira un video in cui si vedono 10 pagine di necrologi (11 pagine il 14 marzo) sull’Eco di Bergamo, mentre un mese prima la pagina era solo una.
Il 18 marzo il tutto diventa ancora più chiaro, con le drammatiche immagini dei camion dell’Esercito che portano via le bare da Bergamo per cremare i corpi in altre province, dal momento che il forno crematorio della città non risulta più sufficiente.
Qui i tamponi fatti sono pochi, ma la regione sostiene che non ci siano problemi. Le persone però muoiono in casa con una polmonite e non vengono mai testate, non entrando così nei conteggi dei deceduti a causa del coronavirus.
Insieme all’agenzia di ricerca e analisi dati InTwig, L’Eco di Bergamo e il suo giornalista Isaia Invernizzi, ora a Il Post, a fine marzo contattano i comuni della provincia di Bergamo per avere dei dati sui decessi. Rispondono i sindaci di 91 comuni su 250, pari al 50% della popolazione, e si scopre che i veri decessi riconducibili al coronavirus sono 4.500 contro i 2.060 ufficiali sottoposti a tampone.
I dati Istat sui decessi, inoltre, mostrano che a Bergamo a fine marzo negli anni precedenti in media morivano 40 persone al giorno, mentre nel peggior giorno della pandemia qui sono arrivati a esserci 280 decessi. In tutto il mese di marzo, qui i decessi sono cresciuti di quasi il 600% rispetto agli anni passati.
Del resto, la stessa indagine sierologica dell’Istat evidenzia come la maggiore sieroprevalenza sia proprio nel bergamasco: nella provincia il 24% della popolazione ha gli anticorpi che dimostrano un contagio precedente. Nella Bassa Val Seriana, la zona più colpita della provincia, è stata condotta tra luglio e agosto un’altra campagna con test sierologici: in totale sono stati eseguiti 22.559 test, di cui il 41,8% è emerso essere positivo. Il comune di Bergamo invece ha testato tra giugno e luglio 21.716 persone, di cui 4.657 sono risultate positive (21,4%).
Maggio – settembre: i pochi casi e l’estate
In Italia la situazione grazie al lockdown migliora fortemente e il 4 maggio il Governo allenta le misure restrittive, riaprendo le attività produttive essenziali e permettendo le visite ai congiunti. Il 18 maggio aprono poi esercizi commerciali al dettaglio, musei e attività come bar, ristoranti e parrucchieri, e dal 3 giugno vengono permessi i movimenti tra le regioni. Ancora, l’11 giugno vengono aperte le ultime attività ancora chiuse, come cinema e teatri, e diverse regioni autorizzano anche le discoteche ad aprire.
Per diversi mesi i contagi rimangono così a livelli molto bassi: è in questo periodo che spunta la teoria senza fondamento della mutazione che avrebbe indebolito il virus. Si inizia anche a parlare di carica virale minore, suscitando un dibattito che però si tiene quasi esclusivamente in Italia.
Ad agosto iniziano ad esserci dei segnali di malfunzionamento del sistema di tracciamento. In particolare, in Sardegna a fine agosto c’è un’alta circolazione del virus (per gli standard di quel momento) che porta le regioni dove attraccano i traghetti provenienti dalla Sardegna a istituire posti in cui effettuare i tamponi a chi arriva da lì. A settembre, poi, i casi crescono molto rispetto alle altre regioni in Liguria e in particolar modo alla Spezia.
Sono anche di quel periodo le teorie secondo cui si stavano testando solo persone asintomatiche e che il maggior numero di tamponi poteva spiegare sostanzialmente tutto. In entrambi i casi, però, si trattava di semplificazioni eccessive.
Ma in quel periodo si riteneva che l’Italia stesse facendo particolarmente bene. Il dibattito pubblico era incentrato sulla riapertura degli stadi e non su come evitare che accadesse anche in Italia quello che già stava succedendo in altri paesi europei: in Italia la prima settimana di settembre si registrarono poco più di 9.000 casi, ma in Francia erano già a 47.000 e in Spagna a 62.000 (la popolazione spagnola è un quarto in meno di quella italiana, mentre quella francese il 10% in più).
In Francia nei primi giorni di settembre il governo cambia la durata dell’isolamento riducendola a 7 giorni, “vale a dire il periodo durante il quale – afferma il premier Jean Castex – c’è un rischio reale di contagio”. Uno studio preliminare di quei giorni afferma del resto che tre quarti delle infezioni si verificano tra 2-3 giorni prima e 2-3 giorni dopo la comparsa dei sintomi.
A fronte dell’aumento dei casi in Francia, il Governo italiano impone a chi arriva da lì di fare un tampone, ma a fare controlli ai principali valichi di frontiera non c’è nessuno. Una norma simile era già stata approvata per alcuni paesi, come la Grecia, ad agosto.
A fine settembre l’Oms pubblica un video sulle sue pagine social in cui elogia l’Italia, e sia i giornali italiani che quelli stranieri scrivono che l’Italia sta agendo molto bene per evitare la seconda ondata.
#Italy 🇮🇹 was the first Western country to be heavily affected by #COVID19. The government & community, across all levels, reacted strongly & turned around the trajectory of the epidemic with a series of science-based measures. This video tells the story of 🇮🇹’s experience. pic.twitter.com/ZjGNAuZnyl
— World Health Organization (WHO) (@WHO) 25 settembre 2020
Ottobre-dicembre: la seconda ondata
È ad ottobre che la seconda ondata arriva anche in Italia. I casi a inizio ottobre sono poco più di 2.000 al giorno, a metà ottobre 7.000, a inizio novembre 25.000 e a metà novembre 35.000. Il picco è di 40.000 casi il 13 novembre.
Anche in questa seconda ondata i casi sono stati sottostimati, sebbene probabilmente meno che nella prima. I tamponi, infatti, non sono riusciti a tenere il ritmo e rapidamente il tasso di positività è iniziato a salire da poco più del 2% di fine settembre al 16% di metà novembre. Allo stesso tempo, i tamponi in quel mese e mezzo sono raddoppiati arrivando a un picco di 250.000 al giorno.
Ma ad essere aumentati non sono stati solo i casi, perché purtroppo anche i decessi hanno seguito una dinamica simile. Ai primi di ottobre i morti giornalieri per coronavirus sono poche decine, mentre ai primi di dicembre sono 750, con un picco di 993 il 3 dicembre. La forte crescita dei decessi ha dimostrato che il virus non è davvero mutato e che quando la circolazione è alta anche i decessi lo sono.
Un’importante differenza tra la prima e la seconda ondata si trova però nella distribuzione del virus: anche in questi ultimi mesi le regioni settentrionali sono state le più colpite, ma il peso ospedaliero è stato maggiormente distribuito tra le regioni. A fine novembre, nel momento del picco, ci sono state 34.600 persone ricoverate nei reparti e 3.800 in terapia intensiva. Va comunque considerato che rispetto alla prima ondata le persone ancora in ospedale per le conseguenze della Covid-19, ma negative al Sars-Cov-2, vengono ora contate tra i guariti.
Con la riapertura delle scuole a settembre si inizia a cercare di capire il loro ruolo nella diffusione del virus. Nella prima ondata, infatti, il Governo chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. In Italia non esistono però dati ufficiali sui contagi nelle scuole, anche perché i dati raccolti dal Ministero dell’istruzione non vengono diffusi pubblicamente. Alcuni lavori di Wired e del fisico Alessandro Ferretti suggeriscono però che l’incidenza dei contagi nelle scuole non sia secondaria, mentre il 23 dicembre lo European Centre for Disease Prevention and Control ha diffuso un documento in cui afferma che le scuole hanno inciso poco nella diffusione del coronavirus (il report è basato su un questionario a cui hanno risposto 17 paesi su 31, ma l’Italia non è tra questi).
Durante ottobre, con l’aumento dei casi, riaffiora nel dibattito Immuni, l’applicazione sviluppata per aiutare le autorità sanitarie a contenere l’epidemia facilitando il tracciamento dei contatti. Alcuni commentatori sostengono la problematicità del fatto che si venga messi in quarantena dopo aver ricevuto una notifica, e che questo sarebbe il motivo dei pochi download.
Nella realtà, le regioni stanno solo seguendo le linee guida per il contact tracing delineate dall’Iss a giugno. Anche i Centers for Disease Control and Prevention, importanti organismi di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti, ritengono che dopo un contatto con un positivo servano 14 giorni di quarantena, sebbene il test sia negativo. Il motivo è il periodo di incubazione del virus di cui si è già parlato: nei primissimi giorni dopo un contatto è improbabile riscontrare la positività della persona, mentre il miglior momento per rilevarla si ha subito dopo l’emersione dei sintomi.
A ottobre vengono anche cambiate le regole per l’isolamento: il Ministero della salute stabilisce che gli asintomatici possono uscirne dopo 10 giorni dalla positività e con un solo test negativo, mentre per i sintomatici devono passare 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, 3 giorni da quando scompaiono e hanno bisogno di un test negativo. In tutti i casi, se non si hanno più sintomi dopo 21 giorni si può porre fine all’isolamento. In Italia nel momento di picco si è arrivati ad avere 800.000 persone in isolamento.
In questa seconda ondata il Governo italiano si mostra molto più titubante della prima nel prendere decisioni su come arginare i casi: l’8 ottobre rende la mascherina obbligatoria sia all’aperto sia al chiuso; il 13 ottobre impone nuove regole per ristoranti, cinema, teatri e altre attività; il 26 ottobre musei, cinema e teatri vengono chiusi e si stabilisce che bar e ristoranti devono chiudere alle 18. Nel frattempo, diverse regioni impongono il coprifuoco tra le 23 e le 5.
Il 3 novembre con un nuovo decreto il Governo cambia approccio: chiude le scuole superiori, divide le regioni in tre colori in base ai criteri epidemiologici a cui si applicano restrizioni diverse e applica un coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5. Le zone rosse e arancioni si dimostrano efficaci nel ridurre i casi e portano abbastanza rapidamente a un sensibile miglioramento della situazione, e i dati sulla mobilità mostrano come le restrizioni siano state rispettate.
Uno dei problemi di questo sistema è però l’eccessivo peso che viene dato all’indice di riproduzione effettiva Rt: per essere classificati come zona arancione o rossa serve avere un Rt alto, cosa che permette al Veneto di rimanere in zona gialla a lungo tempo nonostante il peggioramento evidente della situazione.
Una maggiore velocità del Governo nell’adottare le restrizioni, in particolar modo considerando cosa stava succedendo nel resto d’Europa, avrebbe molto probabilmente evitato un numero così alto di decessi. Adottare le zone rosse prima avrebbe potuto evitare almeno un raddoppio, che in quel momento avveniva settimanalmente, dei casi.
In vista delle festività natalizie, in cui diversi italiani si spostano per tornare dalle proprie famiglie, per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio il Governo decide in via precauzionale di mettere l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e in zona arancione in tutti gli altri. A partire dal 7 gennaio dovrebbero invece tornare in vigore i colori differenziati tra regioni.
Il 2020 in Italia termina con le prime vaccinazioni somministrate negli ospedali italiani a partire dal 27 dicembre: l’obiettivo per il 2021 è riuscire a vaccinare un sufficiente numero di persone, circa il 60-70% della popolazione, affinché si possa tornare progressivamente ad una vita normale e lasciare alle spalle una pandemia che ha avuto conseguenze drammatiche.

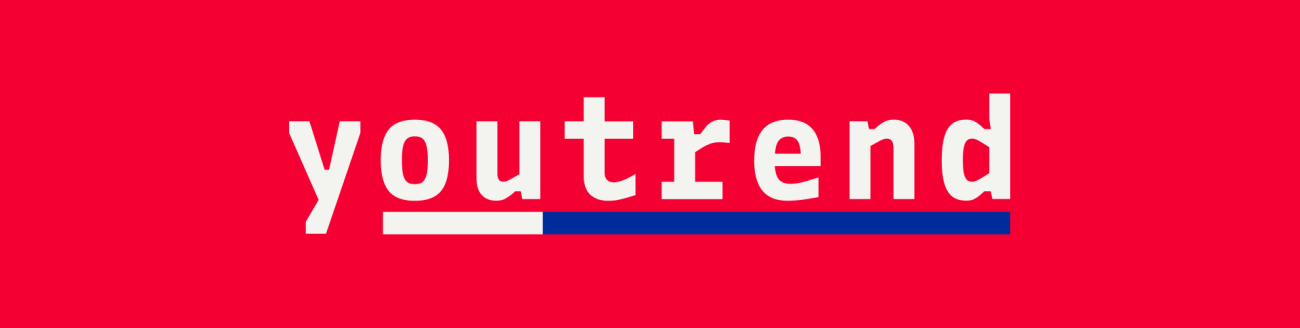
Commenta