Il prossimo 3 novembre, negli Stati Uniti, non si vota solo per la Presidenza. Si vota anche per 35 seggi al Senato e per il rinnovo completo della Camera dei Rappresentanti. La cosa non è secondaria, anzi: senza un Congresso dalla sua parte, il Presidente può incontrare grandi difficoltà nel suo mandato.
La gara più serrata è al Senato perché lì i numeri sono molto ristretti: ogni Stato dispone di due senatori indipendentemente dalla popolazione, per un totale di 100 Senatori. Attenzione però: il Senato si rinnova solo per un terzo, perché si vota ogni due anni e ogni Senatore rimane in carica sei anni.
In queste settimane Luciana Grosso ci racconta allora le sfide più delicate, avvincenti e cruciali per diventare o restare Senatore degli Stati Uniti e, di fatto, avere nelle mani il destino di milioni di persone.
Oggi siamo nel Delaware, decima e ultima tappa del nostro viaggio oltreoceano.
L’ultima tappa del nostro viaggio attraverso le elezioni più complicate, interessanti e in bilico per il Senato USA si occupa del Delaware. In realtà qui le cose dovrebbero andare più che lisce per i democratici, sia perché lo stato è parte del blue wall, sia perché è l’home state di Joe Biden.
Ma le cose da dire non mancano.
Primo perché il Delaware non è uno stato qualsiasi, ma è il “primo stato” nel senso che, nel 1787, fu il primo a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti e ad aderire all’Unione. In pratica è il posto dove sono nati gli Stati Uniti.
In secondo luogo, la candidata dei repubblicani è un tipo che potremmo definire sui generis dal momento che ha sostenuto a lungo QAnon (anche se ora il suo sostegno pare essersi raffreddato, visto che considera QAnon stesso una macchinazione dei poteri forti) e si è definita orgogliosamente terrapiattista, oltre ad essere cristiana radicale e molto vicina al suprematismo bianco.
Terzo perché in rappresentanza di questo stato, come anticipato, Joe Biden è stato senatore per 36 anni.
Una candidatura a cui nessuno credeva
Nel novembre del 1972 Joe Biden non aveva ancora compiuto 30 anni, l’età minima per diventare senatore, ma siccome li avrebbe compiuti entro la fine dell’anno elettorale (il suo compleanno è il 20 novembre) per le leggi americane aveva diritto di candidarsi e di venire eletto.
Ma se candidarsi era una faccenda relativamente semplice, conquistare il seggio, per un misconosciuto politico locale di 29 anni, era una faccenda assai complicata. Questo per due ragioni. Innanzitutto, Biden era un politico praticamente esordiente, senza un soldo e alla cui candidatura neppure il suo partito, quello democratico, credeva. In secondo luogo, il giovane e misconosciuto Biden correva contro un politico potentissimo, senatore da trent’anni, popolarissimo, considerato imbattibile e amico di Richard Nixon in persona: Caleb Boggs, una specie di corazzata elettorale.
Boggs era considerato talmente imbattibile che nessun democratico voleva correre contro di lui. Nessuno. Del resto, perché perdere faccia, soldi e tempo in una campagna elettorale senza speranza?
Così Boggs – che pochi mesi prima aveva annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalla vita politica, salvo poi venir convinto da Richard Nixon a ricandidarsi – sembrava destinato a cercare la rielezione senza nessuno sfidante, perché nessuno voleva perdere. Nessuno tranne un ragazzo che da perdere non aveva niente: Joe Biden.
A quell’epoca Biden era un giovane avvocato e consigliere in una contea del Delaware, una carica di poco conto. Aveva pure un passato da repubblicano, anche se poi, man mano che i repubblicani si spostarono su posizioni razziste, lui si era spostato verso i democratici.
All’inizio della campagna elettorale, a luglio, i punti percentuali che secondo i sondaggi separavano Biden da Boggs erano 30: un abisso.
Ma la cosa bella della politica è che è un po’ come il calcio: non è finita fino a quando non è finita. E in una partita secca può succedere di tutto: la politica va veloce, le cose cambiano, le persone cambiano, le idee circolano. E anche le partite che sembrano scontate (come Clinton versus Trump, per esempio) alla fine possono cambiare e possono ribaltarsi.
E infatti Biden, aiutato dalle dimensioni molto ridotte del Delaware, che gli consentivano di spostarsi da un capo all’altro dello stato con pochissima spesa, aiutato dal suo carisma e, per paradosso, proprio dal suo essere misconosciuto e giovane, prese a guadagnare terreno. Un comizio alla volta, un elettore alla volta.
La sua campagna si concentrò sul ritiro dal Vietnam, l’ambiente, i diritti civili, i trasporti di massa, una tassazione più equa, l’assistenza sanitaria. Ma soprattutto sul suo essere giovane, nuovo, sconosciuto: l’unica arma che, guarda tu, oggi Biden non può proprio sfoderare. A quel tempo, ragazzo di 29 anni, Biden poteva permettersi di insolentire il suo attempato concorrente con slogan come “La generazione di Boggs sognava di sconfiggere la poliomielite. Noi combattiamo l’eroina”. Oppure “Per Boggs una tassa ingiusta era quella elettorale del 1948. Per noi lo è quella sul reddito del 1972”.
L’età usata come grimaldello: chissà che faccia avrebbe fatto il ventinovenne Biden se gli avessero detto che a 78 anni avrebbe sfidato un 74enne per la Casa Bianca. Comunque sia, la campagna si dimostrò azzeccata, la corazzata Boggs si rivelò meno corazzata del previsto e Joe Biden vinse quell’elezione per 3.000 voti.
Senator Biden
Quel che è successo nelle settimane immediatamente successive all’elezione di Joe Biden è cosa nota e fa ormai quasi parte della leggenda: la moglie e la figlia morte in un incidente d’auto poco prima di Natale; lui che vuole dimettersi dal Senato e viene supplicato dal partito di non farlo; l’ordine da lui impartito ai commessi del Campidoglio di interromperlo, qualsiasi cosa stesse facendo, se fosse arrivata una telefonata dai suoi figli; la sua vita da pendolare per essere sempre a casa per cena.
Ma c’è altro da dire sul senatore Joe Biden: per esempio, nei suoi anni nella Camera alta si è sempre collocato su posizioni liberal (ambiente, diritti civili, controllo delle armi, protezione delle periferie e delle categorie considerate più deboli come gli anziani, le minoranze etniche o gli abitanti delle periferie più povere), anche se con una prospettiva centrista, fedele alla sua giovanile militanza repubblicana.
Per questo il suo score non riporta solo voti e battaglie di sinistra, ma anche posizioni centriste o vicine ai conservatori che oggi pesano (in entrambi i sensi) nella sua campagna elettorale: da un lato, lo rendono potabile ai repubblicani moderati; dall’altro, lo rendono indigesto alla sinistra del partito, sia a quella esigua dei #neverBiden, sia a quella, più nutrita, dei sostenitori di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, che non fanno mistero di votarlo turandosi il naso.
Tra i voti più controversi di Joe Biden senatore c’è quello a favore del reaganiano Comprehensive Crime Control Act, legge che decise di aumentare le sanzioni federali per coltivazione, possesso o commercio di marijuana (Biden stesso, anni dopo, ha definito il suo appoggio a quel testo un “grosso errore”); oppure, nel 1993, la volta in cui Biden votò a favore della norma che considerava l’omosessualità incompatibile con la vita militare; oppure ancora, nel 1996, il voto di Biden a favore del Defense of Marriage Act che vietava al governo federale di riconoscere qualsiasi matrimonio tra persone dello stesso sesso (il che è un paradosso se si pensa che fu proprio Biden a forzare la mano all’amministrazione Obama sul riconoscimento dei matrimoni gay).
Il “dopo-Biden”
Quando nel 2009, dopo 36 anni, Biden lasciò il suo seggio al Senato per seguire Barack Obama alla Casa Bianca, il vuoto che si aprì fu grande. Ci furono elezioni speciali, alle quali corsero la repubblicana Christine O’Donnell e il democratico Chris Coons, presidente della Contea di New Castle. Coons vinse, ed è tutt’ora in carica e in cerca di rielezione.
Coons è un democratico atipico. Da un lato ha posizioni molto più a sinistra di Biden: per esempio è stato per anni attivista e volontario per le charities che si occupano di senzatetto. Dall’altro è un ferventissimo cattolico. Dall’altro ancora, come Biden, ha un passato da repubblicano, tanto che nel 1980, a 17 anni, fu volontario della campagna di Ronald Reagan.
Nonostante questo curriculum decisamente composito, oggi Coons è considerato uno dei democratici più saldamente liberal dell’emiciclo: è uno strenuo sostenitore del diritto all’aborto e un fermo oppositore della circolazione delle armi (la National Rifle Association lo detesta). Nel 2016 il suo nome circolò come possibile sostituto, di matrice dem, del giudice della Corte suprema Antonin Scalia.
Ad oggi, la sua rielezione appare scontata ma comunque interessante. Questo perché offre la misura di quale sia la strategia in voga, di questi tempi (e verosimilmente anche nei prossimi) negli Stati Uniti: lì dove le elezioni sono in bilico, si candidano figure centriste, capaci di contendersi il voto del centro; lì dove le elezioni sono considerate sicure, invece, si osano candidati molto polarizzati. Potrebbe sembrare ovvio ma non lo è, poiché spesso la politica procede come un pendolo: quando sarà conclusa la fase del trumpismo, che ha tirato il pendolo verso destra, ne seguirà un’altra che porterà, con spinta uguale e contraria, il vento americano verso sinistra.
La candidata terrapiattista
Una prova chiara di come il pendolo stia oscillando con forza ce la offre la candidata repubblicana al Senato Lauren Witzke. La sua è, come spesso capita in queste elezioni, una storia interessante: è infatti una ex tossicodipendente e una ex trafficante di droga per il cartello messicano (non è un segreto, lei stessa ne ha parlato apertamente).
Two years ago, I was a hopelessly addicted pawn for drug trafficking. The Lord pursued a sinner like me, wrecked my world, and now I’m the GOP front runner candidate for US Senate in the state of Delaware.
Never forget how big our God is.
He is able! #AmericaFirst2020 https://t.co/i5GanriKqw— Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) March 4, 2020
Dopo quella vicenda si è poi convertita alla chiesa catecumenale e ha sposato in pieno (e anche di più) le posizioni più estreme del trumpismo complottista. Si è per esempio avvicinata a QAnon, salvo poi allontanarsene poco dopo ritenendo che anche QAnon faccia parte di un gigantesco complotto di distrazione di massa ordito dai dem per distogliere l’attenzione dai loro sordidi traffici. Si è anche autodefinita una terrapiattista, contesta la ricostruzione ufficiale degli attentati dell’11 settembre, vorrebbe la sospensione di almeno di 10 anni di ogni forma di immigrazione e, soprattutto, considera la fede religiosa il fondamento di ogni azione politica (per esempio ha proposto che i finanziamenti federali ai programmi di recupero dall’abuso di sostanze siano dati solo a chi propone un percorso religioso).
Difficilmente Lauren Witzke passerà la prova del voto. Ma ha ampiamente vinto, seppure con questo curriculum discutibile, le primarie repubblicane (56%). Il che significa che, anche se Lauren Witzke dovesse perdere, in giro ci sono elettori che scelgono e credono in candidati così. E questi elettori, con ogni probabilità, sono qui per restare.

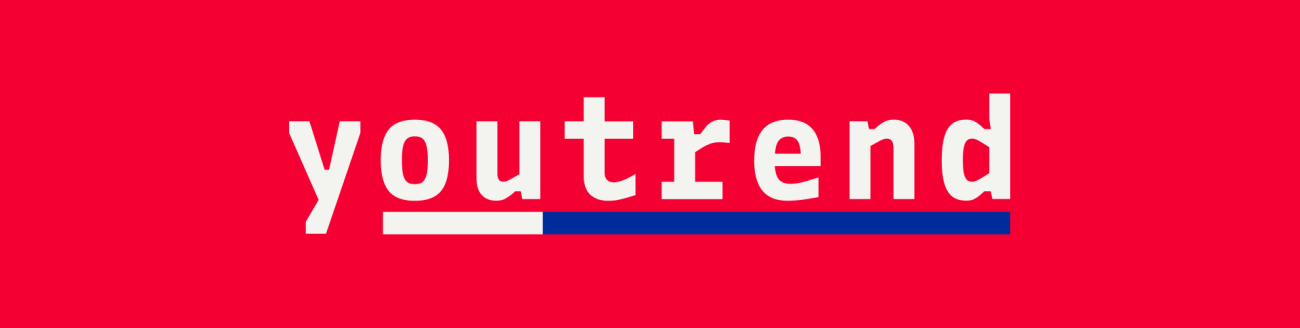
Di certo anche un alieno assassino è preferibile ad un qualsiasi candidato Dem.
Brava, grazie della serie che ho letto con molto interesse. Un excursus non solo sui candidati ma anche sulla società americana e sulla loro storia.