Il prossimo 3 novembre, negli Stati Uniti, non si vota solo per la Presidenza. Si vota anche per 35 seggi al Senato e per il rinnovo completo della Camera dei Rappresentanti. La cosa non è secondaria, anzi: senza un Parlamento dalla sua parte, il Presidente può incontrare grandi difficoltà nel suo mandato.
La gara più serrata è al Senato perché lì i numeri sono molto ristretti: ogni Stato dispone di due senatori indipendentemente dalla popolazione, per un totale di 100 Senatori. Attenzione però: il Senato si rinnova solo per un terzo, perché si vota ogni due anni e ogni Senatore rimane in carica sei anni.
In queste settimane Luciana Grosso ci racconta allora le sfide più delicate, avvincenti e cruciali per diventare o restare Senatore degli Stati Uniti e, di fatto, avere nelle mani il destino di milioni di persone.
Oggi ci spostiamo in Georgia, terza tappa del nostro viaggio oltreoceano. Eccezionalmente, qui a novembre non si eleggerà solo uno dei due senatori dello Stato, ma entrambi.
La Coca Cola. La CNN. Ray Charles. La musica trap. Via col vento. Jimmy Carter. Ben Bernanke. Julia Roberts. Il movimento per i diritti civili. Le Olimpiadi del 1996 con Muhammad Ali che accende il braciere.
Sono queste, e sono solo le prime che vengono in mente, alcune tra le cose che si associano più di frequente allo stato della Georgia, uno dei più importanti d’America, uno dei più grandi, uno dei più ricchi, uno dei più controversi, uno dei più interessanti.
La Georgia è uno stato che, oltre a essere crocevia per la cultura e la società, ha avuto e ha un enorme peso politico. Non solo perché esprime 16 grandi elettori quando si tratta di scegliere il Presidente, ma anche perché è stato per quasi un secolo una roccaforte democratica, poi, per cinquant’anni, una roccaforte repubblicana (vinta solo da Jimmy Carter e Bill Clinton, due candidati del sud, rispettivamente della Georgia e dell’Arkansas) e ora è diventato, un po’ all’improvviso, uno swing state, come si chiamano quegli stati nei quali la vittoria di questo o quel partito non è mai scontata.
Oltre a tutto questo, che già basta e avanza per rendere le elezioni in Georgia cruciali, occorre aggiungere che quest’anno, qui, si verifica una condizione assai rara, per non dire unica: si vota per entrambi i seggi del Senato. Non succede praticamente mai, perchè le elezioni per il Senato sono pensate in modo che i due senatori che ogni stato elegge, e che restano in carica sei anni, siano sempre sfalsate di due anni. Invece, quest’anno, per una serie di ragioni, questa alternanza temporale è saltata, e si vota per tutti e due i senatori. Il che significa che, se ai repubblicani va bene, potrebbero confermare i loro due seggi, se invece gli va male, rischiano di perderli entrambi, come un jackpot al contrario.
I due seggi vanno al rinnovo per due ragioni diverse: uno è arrivato a scadenza naturale, l’altro invece è vacante da un anno e dallo scorso gennaio è stato, come da prassi, affidato a una reggente. Se vi sembra complicato, ci spiace dirvi che in realtà lo è ancora di più: per ciascuno dei due seggi si vota con sistemi elettorali differenti.
Nel caso del primo seggio, quello arrivato a scadenza naturale, si vota con il solito sistema: due candidati, uno contro l’altro, però non vince chi prende più voti, ma solo chi supera il 50%. Se non ce la fa nessuno, si va al ballottaggio.
Nel caso del secondo seggio, invece, le cose sono diverse. Si tratta di una special election, ossia di un’elezione che non si sarebbe dovuta svolgere, ma che, invece, si svolge. Secondo le leggi della Georgia, le elezioni speciali non sono come tutte le altre, ma sono jungle elections, ossia tutti contro tutti: sulla scheda ci saranno i nomi di tutti i candidati possibili, come se si trattasse di una summa tra primarie e elezioni (in via teorica ci possono essere anche tutti candidati dello stesso partito). Alla fine, vince chi raggiunge almeno il 50% dei voti, ma se nessuno tra i candidati ce la fa, si rivota in una specie di ballottaggio tra i primi due.
Tutti i sondaggi, per entrambe le elezioni, sono considerati tie, cioè in bilico, cosa che il Partito Repubblicano, storicamente molto forte da queste parti, non si aspettava, teme e stenta a comprendere.
Noi, invece, ci proveremo. Ma prima ci tocca un breve excursus storico.
La terra rossa di Tara
Per capire cosa sta succedendo nella politica di oggi nello stato della Georgia occorre prendere la cosa un po’ alla lontana e partire dalla Guerra Civile che si è combattuta tra il 1861 e il 1865.
Di quella guerra noi europei, in genere, sappiamo poco, e quel poco che sappiamo ci è arrivato dai libri (“Piccole Donne”, per esempio) e dai film (“Via col vento”, che ve lo dico a fare). Nonostante dalle nostre parti quella guerra non sia raccontata e studiata più di tanto, fu una guerra tremenda: morirono 750 mila persone, quasi tutte al sud (il 30% dei maschi tra i 18 e i 50 anni perse la vita). Le ragioni di quella guerra furono tante e diverse, ma la principale e più nota fu la volontà del presidente repubblicano (eletto esclusivamente con i voti del nord) di abolire la schiavitù. Per gli stati del Sud si trattava di una proposta irricevibile, non tanto e non solo per razzismo (che pure c’era), ma per ragioni economiche. Mentre l’economia del Nord si stava sviluppando in senso industriale, con macchine e fabbriche, quella del Sud era agricola e si reggeva esclusivamente sull’impiego, a costo zero, di legioni di schiavi che raccoglievano cotone, canapa, tabacco.
Così, nel 1861, gli stati del Sud prima dichiararono la secessione e, poi, la guerra.
Mal gliene incolse però, perchè, per loro, la guerra fu una catastrofe. Intere città (come Atlanta) furono rase al suolo, il tessuto economico del Sud fu completamente distrutto, la società di metà degli Stati Uniti ne uscì completamente sfaldata.
Sia chiaro: abbiamo letto anche noi delle polemiche dello scorso giugno sulla narrazione in chiave edulcorata, positiva e paternalistica che ci è arrivata dai libri e dal cinema sul “romantico e lento Sud, in cui gli schiavisti non erano poi così cattivi”, e non intendiamo assolutamente avallarle. Ma stiamo provando a raccontare un dato storico: con la guerra e con la sconfitta del Sud finì un mondo intero, perché milioni di persone la cui vita ruotava attorno a un abominio terribile come la schiavitù (di cui “La ferrovia sotterranea” di Colson Whitehead dà una lettura assai più precisa e disturbante di quella macchiettistica che ci arriva da “Via col vento”) si ritrovarono senza più niente. Senza soldi, senza lavoro, senza terra e senza nessun riferimento. Finita la schiavitù, al Sud, non restava più niente.
Una volta qui era tutto Democratic Party
In pratica, alla fine della guerra, i vecchi abitanti del Sud – molti dei quali erano stati ricchissimi proprietari terrieri – si trovarono in uno stato di prostrazione completa e di miseria che mai avevano provato e visto prima. Una devastazione di cui ritenevano direttamente responsabili gli stati del Nord e, più ancora, il Partito Repubblicano di Abraham Lincoln, che aveva distrutto il loro mondo, la loro indipendenza economica, e fatto strame di quello che, sino a pochi anni prima, era stato un posto (almeno per loro) ricco e florido.
Per questo, dalla fine della Guerra in poi, l’unico partito possibile per un elettore del Sud era il Partito Democratico: era l’unico partito che si opponeva ai barbari invasori repubblicani, era l’unico partito che appoggiava schiettamente le posizioni degli ex schiavisti confederati e la loro volontà di segregazione dei neri, oltre che l’unico che ospitava tra le sue fila razzisti e segregazionisti di ogni tipo (Ku Klux Klan incluso). Per anni, i repubblicani non toccarono palla al Sud, tanto che spesso non presentavano nemmeno i loro candidati. Era una battaglia persa in partenza, perché i neri non avevano diritto di voto, e i bianchi votavano solo democratico.
Poi, cento anni dopo, arrivò Lyndon Johnson e il suo Civil Rights Act. A questo punto successe una cosa strana: i neri, i discendenti degli schiavi, al momento di scegliere un partito, scelsero, come era naturale fosse, quello dell’uomo che aveva dato loro i diritti civili, ossia il Partito Democratico. Il problema, però, era che anche i bianchi razzisti militavano tra i democratici. Le fazioni, è evidente, non potevano convivere. Così i segregazionisti fecero fagotto e trovarono casa nelle fila del Partito Repubblicano.
Si è trattato di uno sconvolgimento radicale che ha influenzato la storia degli stati del Sud (dal Texas all’Alabama, dalla Georgia al Mississippi) per decenni, e uno dei più grandi e gravi ribaltamenti della storia politica americana recente. Da allora il Sud degli USA ha smesso di essere una roccaforte democratica, per diventare completamente e convintamente repubblicana. In Georgia, Richard Nixon mietè il 75% dei voti. Reagan il 60%, per dire l’aria. Però, pur essendo uno stato di orientamento repubblicano, la Georgia non lo è in modo solido. Non è inespugnabile: per quasi tutto il ‘900 i suoi senatori sono stati democratici, e così pure tutti i suoi governatori (il primo repubblicano eletto come governatore è stato Sonny Perdue, nel 2002, dando il via a una serie che continua sino ad ora). Non solo: da qualche tempo a questa parte, qualcosa negli stati americani del Sud e in Georgia si sta muovendo: i repubblicani, sì, vincono ancora, ma a ogni elezione lo fanno con un margine sempre più ristretto. Il rosso, che nelle mappe elettorali americane indica gli stati solidamente repubblicani, tende sempre di più al rosa. I risultati sono sempre meno scontati e la sicurezza del GOP sempre meno salda.
Il caos del 2018: la non elezione di Stacey Abrams
Nel 2016, in Georgia, Donald Trump vinse su Hillary Clinton con un margine molto risicato: appena 5 punti percentuali. Due anni dopo si votò per eleggere il governatore dello stato. Da un lato c’era Brian Kemp, un repubblicano superconservatore, supertrumpiano e vagamente razzista. Dall’altro, Stacey Abrams una combattiva afroamericana, avvocato e attivista per i diritti civili. Per tutto il tempo della campagna elettorale, i sondaggi hanno dato lo stato in bilico, anzi, a un certo punto sembrava che Abrams potesse vincere.
Poi, il giorno del voto, qualcosa non ha funzionato.
Circa 400 mila persone (il 75% delle quali era di colore) scoprì di essere stato cancellato dalle liste elettorali per vizi di forma, cambi di indirizzo non registrati, errori di trascrittura. Ergo, circa 400 mila persone non poterono votare. Il che, in un’elezione vinta da Kemp con uno scarto di solo 50 mila voti, fu un problema serio e diede luogo ad accesissime polemiche.
Stacey Abrams non si diede per vinta, chiese la cancellazione del voto e nuove elezioni, ma poi, dopo un po’ (probabilmente su ordine dei gerarchi del Partito Democratico), si arrese e disse di riconoscere che le elezioni erano state vinte da Kemp, anche se, ci tenne a sottolineare, il voto non si era svolto in modo regolare.
Il 2020: le elezioni più complicate di tutte
L’elezione di Kemp e la non elezione di Abrams hanno lasciato strascichi che non si sono mai del tutto rimarginati. Anzi, hanno continuato a scavare negli animi di elettori e cittadini. Sospetti. Paura.
È con queste cose nell’animo che gli elettori della Georgia andranno al voto il prossimo 3 novembre. Per di più con una pletora di candidati.
Al seggio in cui si vota nel modo tradizionale, i candidati sono due: David Perdue (senatore uscente, dato per favorito, super conservatore e alleato fedelissimo di Donald Trump) e Jon Ossoff (33 anni, plurilaureato, in politica da quando era ragazzo e di recente giornalista d’inchiesta).
Al seggio in cui si vota con una jungle election, invece, le cose sono più complicate. In corsa ci sono:
Kelly Lynn Loeffler: attuale reggente del seggio al Senato. Plurilaureata, ex giocatrice di basket, supertrumpiana e, dettaglio non da poco, ricchissima: ha sposato Jeffrey Craig Sprecher, fondatore, presidente e CEO di Intercontinental Exchange (colosso della compravendita di materie prime) e presidente della Borsa di New York. Di recente la coppia è stata coinvolta in una brutta storia di insider trading perchè sembra che, il giorno stesso in cui la senatrice ha ricevuto un briefing riservato sull’imminente arrivo della crisi del Covid-19, la coppia abbia venduto decine di azioni di aziende vulnerabili alla pandemia, per comprarne altre di una società, la Citrix, specializzata in software di telelavoro.
Doug Collins: repubblicano, cappellano militare, di fede battista, è stato deputato repubblicano nella House of Representatives dello stato della Georgia. In linea di massima sostiene Trump (quando può; quando non può, come nel caso dei nastri di Access Hollywood, evita di commentare).
Raphael Warnock, anche lui pastore, è candidato per il Partito Democratico. È nato poverissimo, undicesimo di 12 figli, e oggi tiene la messa alla Ebenezer Baptist Church, la chiesa di cui fu pastore Martin Luther King.
Matt Lieberman, democratico, ex insegnante, attivista per i diritti civili e padre single, è un figlio d’arte: suo padre, Joe Lieberman, era il candidato vicepresidente in ticket con Al Gore nel 2000. Si presenta con il programma più a sinistra di tutti.
Ed Tarver, democratico, è dato per favorito. In Georgia lo conoscono bene, perché nel 2005 divenne procuratore distrettuale e, nel sud della Georgia, fu il primo a farlo.
A cosa pensano i georgiani quando votano?
Le prossime elezioni georgiane saranno, per i motivi detti poco sopra, particolarmente complesse.
La ferita delle elezioni del 2018 (Kemp vs Abrams) è ancora aperta, così come lo sono (anzi, lo stanno diventando sempre di più) le ferite del razzismo, delle ingiustizie e del rancore razziale. Il Covid ha colpito duro e, quel che è peggio, lo ha fatto in conseguenza alla decisione del governatore Kemp di allentare le norme di distanziamento sociale e di lockdown.
Inoltre c’è, e campeggia come non mai su queste elezioni, la questione razziale: in Georgia circa il 30% della popolazione è nero; il 10% latino. Il resto è bianco.
Ma i bianchi, va detto, non sono tutti razzisti. Anzi, in realtà non lo è quasi nessuno. Il problema del razzismo in America è un problema sistemico, legato più a come funziona la società che alla testa delle persone. I razzisti, i suprematisti bianchi, quelli del KKK ci sono, certo. Ma sono una minoranza ossessionata più dai fantasmi che ha in testa che da questioni reali.
Nella stragrande maggioranza dei casi, alla gente, non importa nulla del colore della pelle del tizio che si siede di fianco in autobus. Sono piuttosto preoccupati che l’autobus arrivi puntuale, che li porti al lavoro o, ancora di più, di averlo un lavoro per cui valga la pena prendere l’autobus. Oppure di potersi permettere di comprare una macchina, se ne hanno voglia.
Su questo, molto probabilmente, si esprimeranno gli elettori della Georgia, anche perché quello che avevano da dire su razze e colore della pelle lo hanno già detto. E gli è sempre andata male.

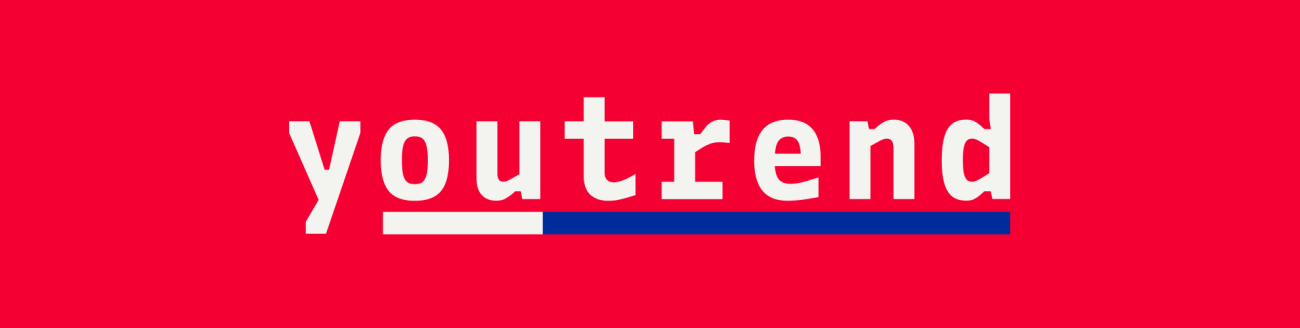
Commenta