Un’elezione “strana”
Le elezioni presidenziali del 1952 negli Stati Uniti sono delle elezioni da ricordare, per tanti motivi. In questa serie di articoli ci stiamo occupando di campagne elettorali che hanno in qualche modo lasciato il segno: perché hanno cambiato un’epoca, perché hanno introdotto un’innovazione particolare, o anche soltanto perché hanno visto il trionfo di un’idea o di uno slogan efficace. Quella di cui parliamo oggi non è una campagna “epocale” nel senso stretto del termine. È la storia di come Dwight Eisenhower, generale dell’esercito statunitense, sia riuscito, dopo 20 anni di dominio democratico, a conquistare la presidenza. Ma non è (solo) per questo che parliamo della sua campagna: il motivo sta nella particolare strategia adottata da Eisenhower, una strategia “da manuale” nel vero senso del termine, dal momento che è stata presa a modello per teorizzare una vera e propria tipologia di strategia, elettorale e politica.
Il contesto: la “nuova America” dopo il New Deal
Nel 1952 gli Stati Uniti sono la prima potenza mondiale, economica e militare. Sono i leader del “mondo libero”, ossia del blocco delle democrazie liberali e capitaliste a cui, da pochi anni, si oppone il blocco comunista guidato dall’Unione Sovietica. La “guerra fredda” è appena agli inizi, e pur non essendo una guerra vera e propria vede gli Stati Uniti impegnati al massimo per affermare la supremazia del loro modello socio-economico e il loro stile di vita (“american way of life”). Sono anche un Paese in continua evoluzione, profondamente trasformato rispetto a ciò che erano solo 20 anni prima: nel 1932, sull’onda della Grande Depressione, era stato eletto per la prima volta un Presidente che prometteva di risolvere i problemi degli americani grazie allo stato e all’intervento pubblico.
Quel presidente era Franklin D. Roosevelt che, con il blocco di riforme conosciute come “New Deal”, introdusse negli USA politiche a mirate a sostenere l’occupazione, tramite imponenti investimenti pubblici e la creazione di grandi infrastrutture finanziate a livello federale. Certo, tutto ciò comportò un significativo aumento della pressione fiscale e della presenza dello stato nell’economia, ma contribuì anche a far uscire definitivamente gli Stati Uniti dalla spaventosa crisi economica seguita al crollo delle borse del 1929 e ad accrescere notevolmente il benessere di milioni di americani.
Roosevelt venne premiato con ben tre rielezioni: prima nel 1936, poi nel 1940, poi ancora nel 1944, e secondo alcuni storici, se non fosse morto nel 1945, è probabile che gli americani avrebbero continuato a rieleggerlo. Ma, nel 1948, vinse Harry Truman, vicepresidente di FDR e comandante in capo nel momento in cui gli USA vinsero la Seconda guerra mondiale, decidendo di piegare le ultime resistenze del Giappone con l’utilizzo della bomba atomica. Per il partito Repubblicano si trattò di un brutto colpo: erano convinti che il loro candidato Dewey avrebbe vinto, e che gli americani avrebbero voltato le spalle ai Democratici, ormai al potere da tanti, troppi anni. Non fu così. L’America della libertà, all’inizio diffidente nei confronti del New Deal, si era ormai abituata alle conquiste dello “stato sociale” americano e aveva imparato ad apprezzarle, e non era pronta ad affidarsi ad un partito Repubblicano che quelle conquiste le vedeva ancora con sospetto – se non addirittura con fastidio.
La difficile sfida dei Repubblicani
È in questo scenario che Dwight Eisenhower vinse le primarie Repubblicane. Non si trattò di una vittoria schiacciante: il suo avversario, il senatore conservatore Robert Taft, gli contese la nomination fino all’ultimo. Anche per questo, la sua strada verso la Casa Bianca non si preannunciava come semplice: il contesto, lo abbiamo visto, vedeva i Repubblicani sfavoriti. I Democratici avevano fatto il New Deal, avevano guidato il Paese nella Seconda guerra mondiale, avevano sconfitto le forze dell’Asse e avevano consolidato il primato economico e militare degli USA a livello mondiale. Per di più, il loro candidato presidente non era un estremista: si trattava di Adlai Stevenson, governatore dell’Illinois, un moderato con un atteggiamento da intellettuale. Impossibile giocare una campagna all’attacco di Stevenson, accusandolo di estremismo o di voler portare gli Stati Uniti verso una deriva troppo sinistrorsa. Ci voleva, evidentemente, qualcos’altro.
Quel “qualcos’altro” si chiamava, appunto, Dwight Eisenhower. Nonostante avesse faticato a conquistare la nomination Repubblicana, infatti, “Ike” (il suo nomignolo) era immensamente popolare tra gli americani. Era lui il generale che aveva guidato le truppe americane in occasione dello sbarco in Normandia, fino alla vittoria contro i nazisti. Con un candidato del genere, nel contesto del 1952, una campagna tradizionale di tipo “posizionale” (basata su una contrapposizione tra idee e programmi politici diversi) era del tutto inutile. La campagna di Eisenhower, quindi, puntò tutto sulla figura del candidato. E lo fece con la strategia delle “3 C”.
La strategia delle “3 C”
Quella che noi italiani possiamo prenderci il lusso di chiamare semplicemente “strategia delle 3 C” ha in realtà un nome (o meglio, un codice) ben più complesso: “K1C2” (Roberts, Hammond, Sulfaro, 2012). Non è il nome di un micidiale dispositivo balistico d’avanguardia, ma semplicemente un acronimo che sta per “Korea, Communism, Corruption” (ossia Corea, Comunismo, Corruzione: le 3 C, appunto). Si tratta delle tre principali preoccupazioni degli elettori americani in quel lontano 1952. Da due anni, infatti, gli Stati Uniti si erano impegnati nella guerra di Corea, primo impegno bellico degli USA dalla fine della Seconda guerra mondiale e “anteprima”, per certi versi, di quella che sarà poi la guerra del Vietnam. E, proprio come accadrà in seguito per il Vietnam, anche dalla guerra di Corea gli americani erano preoccupati di come portarla a termine. Il timore di un’escalation che potesse sfociare in guerra (atomica) aperta con l’URSS, era grande.
Il secondo fattore era il comunismo: nel 1952 era già diffusa la sensazione che il nemico fosse non solo quello che parlava russo, ma che potesse nascondersi già in casa propria. Di lì a poco, la paura che gli USA pullulassero di spie comuniste in incognito sarebbe sfociato nella fobia paranoica del maccartismo.
L’ultima delle “C” era quella della corruzione: venti anni di mancato ricambio nella guida del governo federale avevano inevitabilmente agevolato il dilagare della corruzione pubblica, che cominciava ad emergere periodicamente con scandali che destavano stupore e diffidenza nei cittadini americani, che chiedevano azioni forti per contrastare il fenomeno.
Questi tre fattori possono apparire molto diversi, ma hanno in comune un aspetto fondamentale: sono fattori trasversali, non-partisan, cioè non propri di una delle due parti politiche e del suo elettorato. Tutti gli americani volevano che la guerra di Corea finisse il prima possibile; tutti (o quasi) erano decisamente ostili nei confronti del comunismo; e tutti, verosimilmente, volevano meno corruzione. Ecco perché la campagna di Eisenhower è una campagna da manuale: perché la sua strategia fu quella di puntare su questi temi, e fu poi presa a modello da un studioso (Stokes, 1963) che diede loro il nome di “valence issues” (temi imperativi), diversi dai “positional issues” (temi posizionali).
Vincere con i temi imperativi
Perché una strategia del genere, basata sui temi imperativi, funzioni, c’è bisogno che ricorrano alcune condizioni (De Sio, 2011). La prima condizione è che i temi che sono importanti per gli elettori siano declinati in un’ottica imperativa: molti temi classificabili come “valence issues”, infatti, sono banalmente dei temi posizionali “travestiti”; ad esempio, proporre di aumentare il benessere dei cittadini è certamente un tema imperativo, cioè condiviso da tutti: ma diventa posizionale nel momento in cui si passa al dibattere su “come” perseguire l’obiettivo (alzando o abbassando le tasse, aumentando o diminuendo i sussidi, etc). Quindi, bisogna declinare il tema in modo che risulti massimamente condivisibile, al di là delle idee politiche degli elettori.
La seconda condizione è che sia possibile una “attribuzione positiva” del candidato rispetto a questi temi. Nel caso di Eisenhower e delle “3 C”, questo risultò piuttosto semplice: in quanto generale pluri-decorato della Seconda guerra mondiale, ebbe gioco facile a porsi come l’unico in grado di risolvere la crisi bellica in Corea (anche senza specificare esattamente come – appunto); in quanto patriota Repubblicano, costrinse i Democratici sulla difensiva attaccandoli per la loro scarsa determinazione nella lotta contro il comunismo; infine, godendo di una solida reputazione di uomo integerrimo, risultò anche il più credibile nel propugnare una severa lotta alla corruzione.
La terza condizione, è che si riesca, con una campagna elettorale gestita in modo accorto, a imporre il proprio “framing” nell’agenda pubblica. Se i Repubblicani non avessero mostrato sufficiente convinzione nel declinare la strategia imperativa di Eisenhower, avrebbero rischiato di giocare sul terreno dei valori posizionali, dove i Democratici erano pronti a stanarli, accusandoli di voler smantellare il New Deal e gettare, di nuovo, milioni di americani nella povertà.
Così, mentre la campagna di Adlai Stevenson fu mirata a sottolineare la differenza tra il suo partito (“il partito di Roosevelt”) e i suoi avversari (“il partito di Hoover”, presidente in carica nel 1929), quella di Eisenhower puntò tutto sul fatto che “Ike” fosse l’uomo giusto per risolvere i problemi degli americani. Non di una parte: di tutti gli americani.
La campagna del 1952 va ricordata anche per un altro motivo: furono le prima in cui nelle case degli americani era entrata, e si era ormai diffusa, la televisione. Certo, la campagna si faceva ancora principalmente con le affissioni e il mezzo principale di informazione con cui i cittadini potevano seguire i candidati e le loro proposte era ancora la radio. Bisognerà aspettare ancora qualche anno per vedere il primo dibattito televisivo tra due candidati alla Casa Bianca (il famoso Nixon vs Kennedy, nel 1960). Nonostante la “scienza” della comunicazione elettorale in televisione fosse quindi ai suoi inizi, la campagna di Eisenhower riuscì a produrre uno spot che viene studiato ancora oggi: un breve cartone animato in cui una folla di cittadini canta un jingle con il motto della campagna, “I like Ike”. Il messaggio dello spot, come si vede, era perfettamente coerente con la strategia della campagna: il contenuto era il candidato, i suoi valori, le sue caratteristiche.
Lo spot della campagna di Eisenhower del 1952: il motto della canzoncina è “I like Ike” (mi piace Ike).
Come andò a finire?
La strategia di Eisenhower, come avrete intuito, funzionò fin troppo bene: l’ex generale vinse con il 55% del voto popolare e oltre 6,5 milioni di voti in più di Stevenson, ottenendo una “landslide” nel collegio dei Grandi Elettori con cui si assegna la vittoria alle Presidenziali negli Stati Uniti: 442 Grandi Elettori contro i soli 89 ottenuti da Stevenson.
La presidenza di Eisenhower passò alla storia come una delle più amate dagli americani. Secondo uno studio recente (Rottinghaus, Vaughn, 2018) Eisenhower è al settimo posto (su 45) nella classifica della “grandezza” dei Presidenti degli Stati Uniti d’America, dietro a “mostri sacri” come Abraham Lincoln, George Washington, i due Roosevelt (Theodore e Franklin Delano), Thomas Jefferson e il già citato Harry Truman. Né si può dire che la sua presidenza fu rivalutata solo in seguito dai posteri: nel 1956 Eisenhower fu riconfermato alla Casa Bianca per un secondo mandato (di nuovo contro Stevenson) ottenendo ancora più voti e Grandi Elettori (57% e 457, rispettivamente). La sua popolarità restò sempre altissima durante la sua presidenza, spesso con indici superiori al 70%.
Quella di Eisenhower fu una combinazione, forse irripetibile, di un candidato che incarnava perfettamente l’idea della “persona giusta al posto giusto” per risolvere i problemi più sentiti dai cittadini. Una combinazione che, nella storia delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, non si sarebbe mai più replicata, lasciando spazio ad una competizione via via più polarizzata, con i due candidati principali sempre più espressione dei sentimenti e degli umori di una parte dell’elettorato. Ma questa è un’altra storia.
BIBLIOGRAFIA
BUDGE, KLINGEMANN, VOLKENS, BARA, TANNENBAUM, Mapping policy preferences; Estimates for Parties, Electors and Governments 1945-1988, Oxford, Oxford University Press, 2001.
DE SIO, Competizione E Spazio Politico. Le Elezioni Si Vincono Davvero Al Centro?, Bologna, Il Mulino, 2011.
DOWNS, An economic theory of democracy, New York, Harper, 1957.
ROBERTS, HAMMOND, SULFARO, Presidential campaigns, Slogan, Issues and Platforms, ABC-CLIO, 2012.
ROTTINGHAUS, VAUGHN, Ranking of Presidential Greatness, 2018. [LINK]
STOKES, Spatial models in party competition, in American political science review n° 57, 1963.

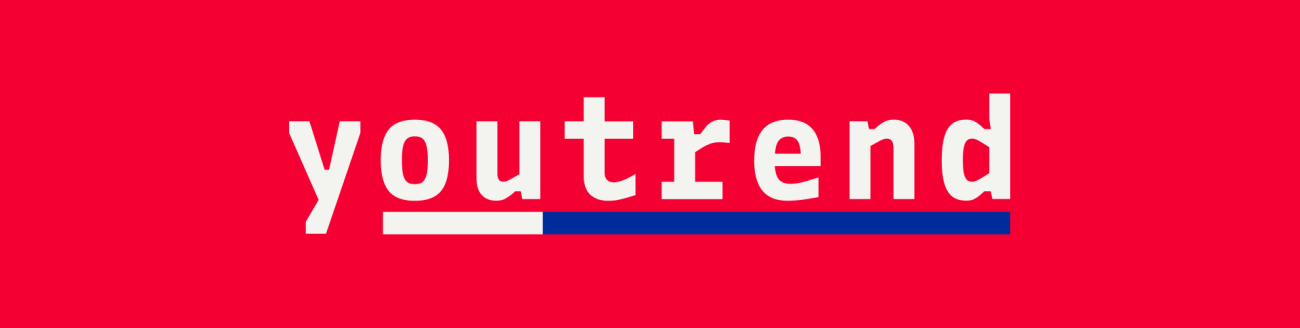
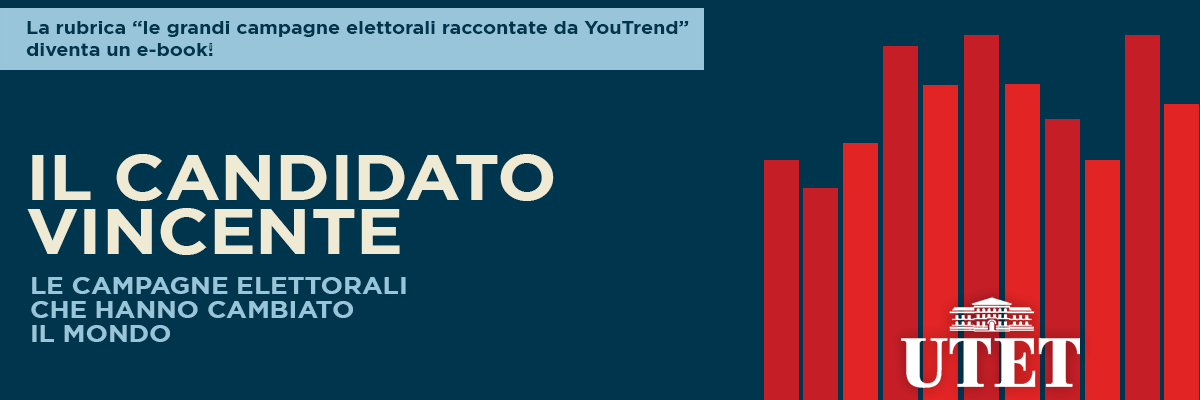
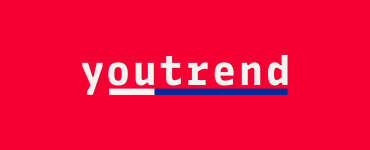
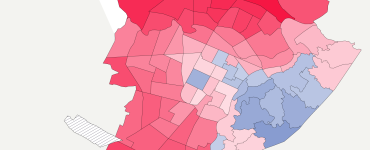
Commenta