Il fascino delle primarie statunitensi risiede in buona parte nella complessità delle “regole del gioco”, che causano campagne elettorali lunghe, spesso molto combattute e usuranti per i candidati.
Negli Stati Uniti non vince chi prende più voti, né alle elezioni primarie né alle elezioni presidenziali: Hillary Clinton prese più voti di Obama nel 2008, ma perse nettamente, così come nel 2000 George W. Bush prese meno voti di Al Gore, ma vinse grazie alla conquista dei voti elettorali della Florida. A differenza delle elezioni generali, però, le primarie funzionano diacronicamente: non si vota in un solo giorno, ciascuno dei 50 stati vota in un momento diverso. Le primarie sono un percorso che dura mesi, e la strategia dei candidati deve considerare elementi diversi. Bastano banali errori di programmazione o eccessivi rischi tattici per trasformare una cavalcata trionfale in una disfatta totale.
La storia recente ci mostra numerosi candidati partiti come frontrunner e poi finiti per ritirarsi anzitempo dalla contesa elettorale. Il 2008 è un anno simbolico da questo punto di vista. Per molti, doveva concludersi a novembre con una sfida scontata. Da una parte, l’ex first lady e senatrice Hillary Clinton. Dall’altra, l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, paladino della Tolleranza Zero, forte di un consenso dovuto all’efficiente gestione post-11 settembre e alla lotta al degrado nei quartieri più pericolosi della Grande Mela. Ma le cose andarono diversamente e le loro campagne naufragarono in modi diversi e inizialmente inaspettati.
La Clinton subì la rimonta straordinaria di un senatore nero dell’Illinois: Barack Obama, indietro di quasi 30 punti nei sondaggi nazionali, puntò tutto sull’Iowa, da subito. Sapeva che, come avvenne nel 2004 con John Kerry, una vittoria in Iowa gli avrebbe garantito un momentum importante, e l’avrebbe spinto in alto nei sondaggi. Così avvenne: Hillary, concentrata in una campagna nazionale, si fece sorprendere nel primo stato e, seppur con un buon 29%, arrivò terza, alle spalle anche di John Edwards. Due giorni dopo, l’attuale presidente le aveva già rosicchiato più di dieci punti a livello nazionale. L’organizzazione capillare di Hillary, che aveva comitati in suo sostegno in ogni angolo d’America, le permise di rimanere in gara e di perdere con dignità, ma la vittoria di Obama in quelle primarie ha ragioni strategiche precise:
• Il già citato momentum guadagnato da Obama a inizio gennaio, con la vittoria in Iowa. Un trionfo che gli ha permesso di affrontare le primarie con un clima d’opinione fortemente a favore e con i supporter decisamente galvanizzati.
• Gli errori di posizionamento di Hillary. Non solo si è spostata al centro troppo presto, parlando a un elettorato diverso da quello che avrebbe votato alle primarie, e permettendo così a Obama di avvicinarsi agli elettori del più lefty John Edwards, ma non si è nemmeno curata di colmare il gap di empatia e umanità che scontava nei confronti del senatore di Chicago. Fredda, distaccata, per alcuni quasi robotica, soffriva molto il paragone con il più simpatico e “alla mano” Obama. Infatti, i rari momenti di umanità della sua campagna (come quando, prima del voto in New Hampshire, scoppiò a piangere in diretta televisiva, o quando, troppo tardi, iniziò a presentarsi ai comizi accompagnata dalla figlia) hanno coinciso con i suoi periodi di crescita e recupero nei sondaggi.
• Lo scontro tra frame impostato da Obama a inizio campagna: “Change vs status quo“. Hillary è rimasta così inevitabilmente inchiodata su posizioni legate al passato in un periodo storico nel quale c’era una forte domanda di rinnovamento, che il senatore dell’Illinois incarnava al meglio. In un momento in cui gli elettori democratici chiedevano “il cambiamento”, Obama rispondeva parlando di cambiamento e di valori, mentre Hillary proseguì la campagna concentrandosi sulla propria affidabilità e competenza.
• L’indebolimento in alcuni target decisivi. Moglie di Bill Clinton, da molti descritto come “il primo Presidente nero” per l’apprezzamento di cui godeva tra le minoranze etniche, Hillary ha trascurato il segmento demografico afroamericano, convinta che lì Obama non sarebbe riuscito a sfondare. La storia è andata molto diversamente. Lo speech diventato noto come “Discorso sulla razza”, ad esempio, permise ad Obama di entusiasmare le minoranze lanciando un messaggio di speranza che non poteva allontanare l’elettorato bianco progressista.
• Infine, lo staff della Senatrice, guidato dal noto stratega Mark Penn, commise errori inaspettati per una struttura fortemente organizzata. Infatti, vennero completamente surclassati da Obama nella strategia territoriale, fallendo gli obiettivi negli stati in cui avevano un consenso maggiore (e dove dovevano “fare il pieno” di delegati) e facendosi trovare impreparati negli stati dove stava emergendo la candidatura più progressista di Obama.
Una campagna tecnica e fredda, condita da molti errori anche organizzativi, contro una campagna di speranze ed emozioni, in un momento storico fortemente favorevole ai cambiamenti epocali. È facile leggere a posteriori le campagne elettorali, ma gli errori macroscopici di Hillary nel 2008 sono stati fondamentali nella vittoria di Obama. La campagna di Rudy Giuliani invece, sempre nello stesso anno, è naufragata molto prima. Favorito e inizialmente in vantaggio nei sondaggi, amatissimo tra i moderati ma accettato anche da una parte della destra per le capacità di gestione sul tema della sicurezza, l’ex sindaco sembrava il candidato ideale per i repubblicani per affrontare le sfide del 2008 a testa alta nonostante lo scarso gradimento del Presidente Bush. Ben presto, però, dovette abbandonare la contesa e ritirarsi dalla competizione. Giuliani scelse da subito di non competere in Iowa e New Hampshire, tenendosi fuori dai primi scontri con l’obiettivo strategico di evitare inimicizie facendosi trovare pronto negli stati successivi, meno importanti da un punto di vista simbolico ma molto più pesanti quanto a numero di delegati. Puntò tutto sulla Florida, che avrebbe scelto il proprio candidato il 29 gennaio, una settimana prima del Super Tuesday, giorno decisivo nel quale si sarebbe votato in alcuni tra gli stati più popolosi e importanti, ma quasi un mese dopo gli early states. Una scelta fatta per non logorarsi nelle prime settimane di campagna e per guadagnare il momentum subito prima dell’appuntamento più importante, che avrebbe di fatto deciso le primarie.
Una scelta rischiosa, che mise in discussione per la prima volta l’approccio strategico “alla Carter/Clinton”, impostato sull’assicurarsi i primi stati a tutti i costi. Brent Seaborn, direttore strategico della campagna, scrisse in un memo riservato poi divenuto celebre “la storia ci darà ragione”. La storia, invece, si rivoltò contro Rudy Giuliani, e questo errore strategico gli costò la Presidenza – o quantomeno la nomination. Infatti, dopo due prevedibili risultati disastrosi in Iowa e nello stato a lui congeniale del New Hampshire, mentre i vincitori delle sfide (da una parte l’evangelico Mike Huckabee, e dall’altra il moderato John McCain) godevano del traino del momentum elettorale, Giuliani, ormai ignorato dai media nazionali e trattato alla pari dei candidati “minori”, iniziò a crollare nelle intenzioni di voto a livello nazionale, subendo la forte rimonta soprattutto di McCain, candidato a lui affine ideologicamente. Giunto terzo in Florida, dove si giocava il tutto per tutto, decise di ritirarsi il giorno stesso e di sostenere lo stesso McCain nelle sfide successive.
Se la storia elettorale ci può insegnare qualcosa, possiamo ricavare diversi insegnamenti da queste campagne elettorali:
• Poche cose, in una campagna a tappe, sono importanti quanto il traino del momentum, ovvero un trend positivo non solo dal punto di vista della crescita nelle intenzioni di voto, ma soprattutto nell’attenzione mediatica e nell’entusiasmo dei propri sostenitori.
• Non tutti gli stati hanno lo stesso peso elettorale, e il valore di una corretta strategia territoriale, alla fine, si rivela determinante.
• Le elezioni sono soprattutto sfide tra diversi frames e messaggi. In un contesto di numerosi messaggi diversi, a prevalere è il candidato che presenta la visione più in sintonia con i bisogni degli elettori, a patto che sia in grado di incarnarla al meglio.
Mancano poche settimane, e finalmente capiremo se Hillary, come sembra, ha imparato davvero la lezione di otto anni fa, e se Donald Trump ricorda ancora la catastrofica cavalcata dell’amico Rudy Giuliani, del quale fu uno dei più attivi sostenitori.

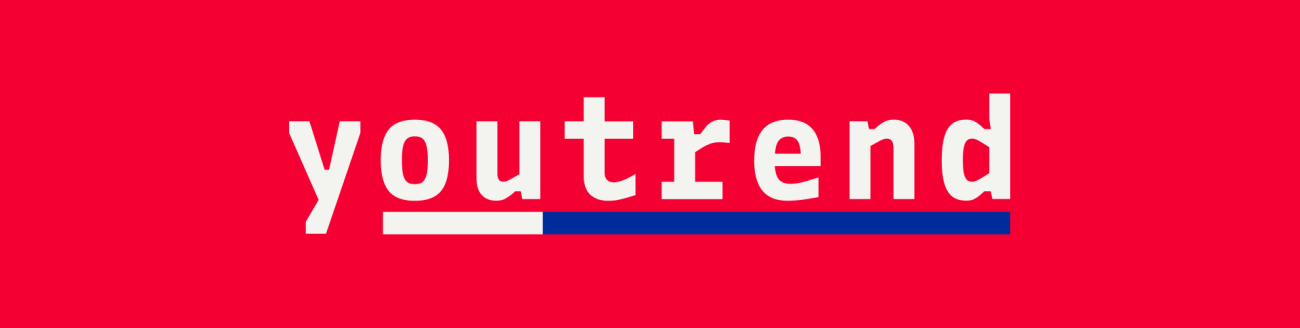
Commenta